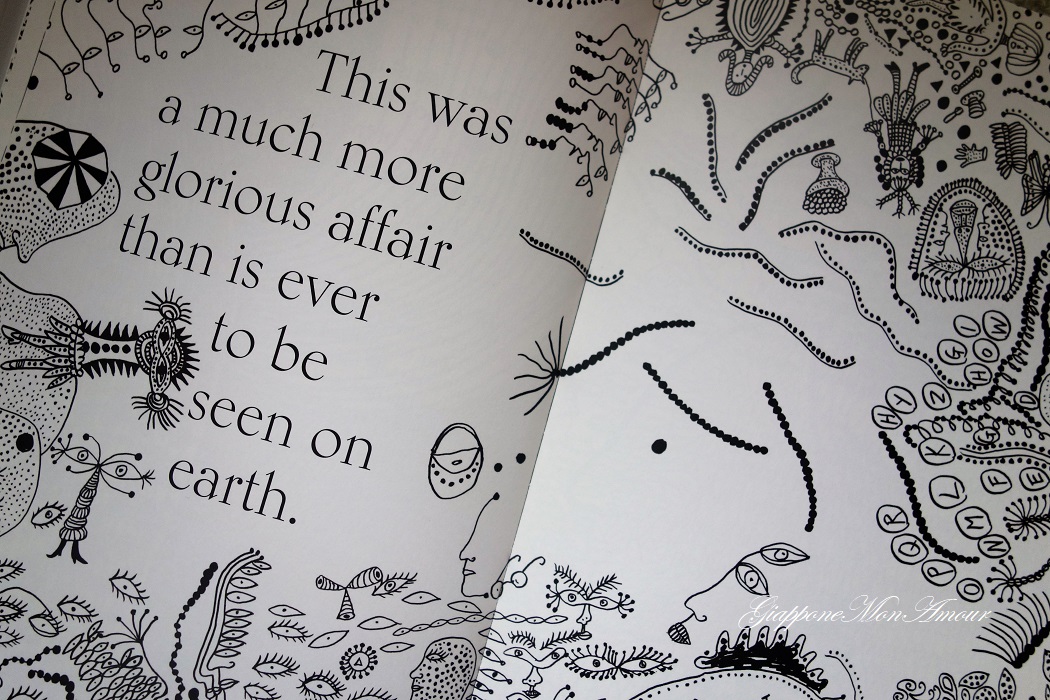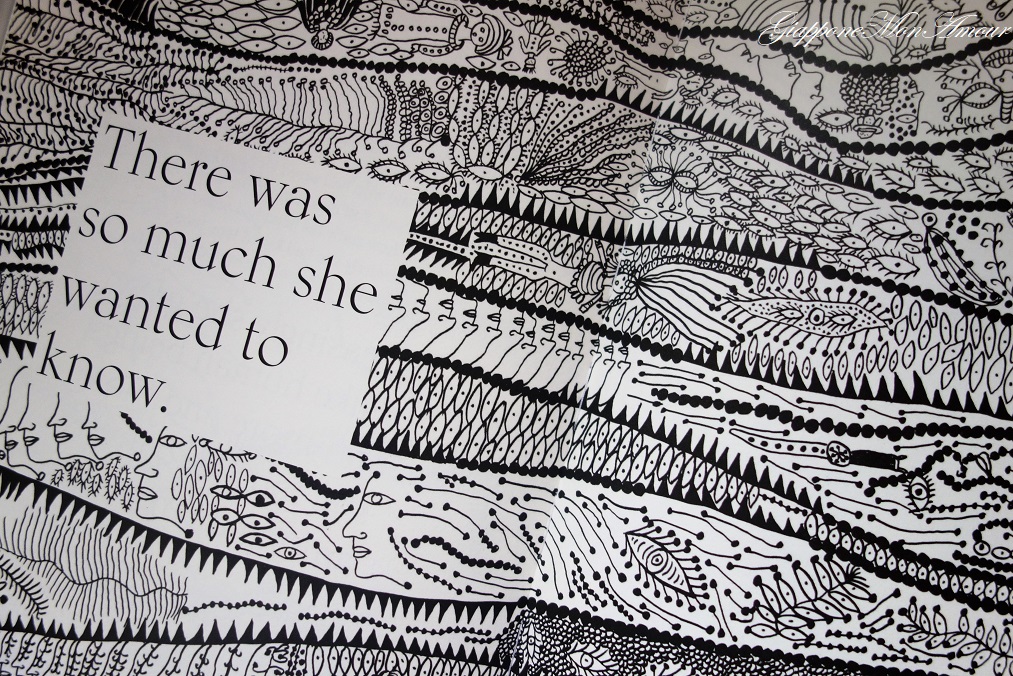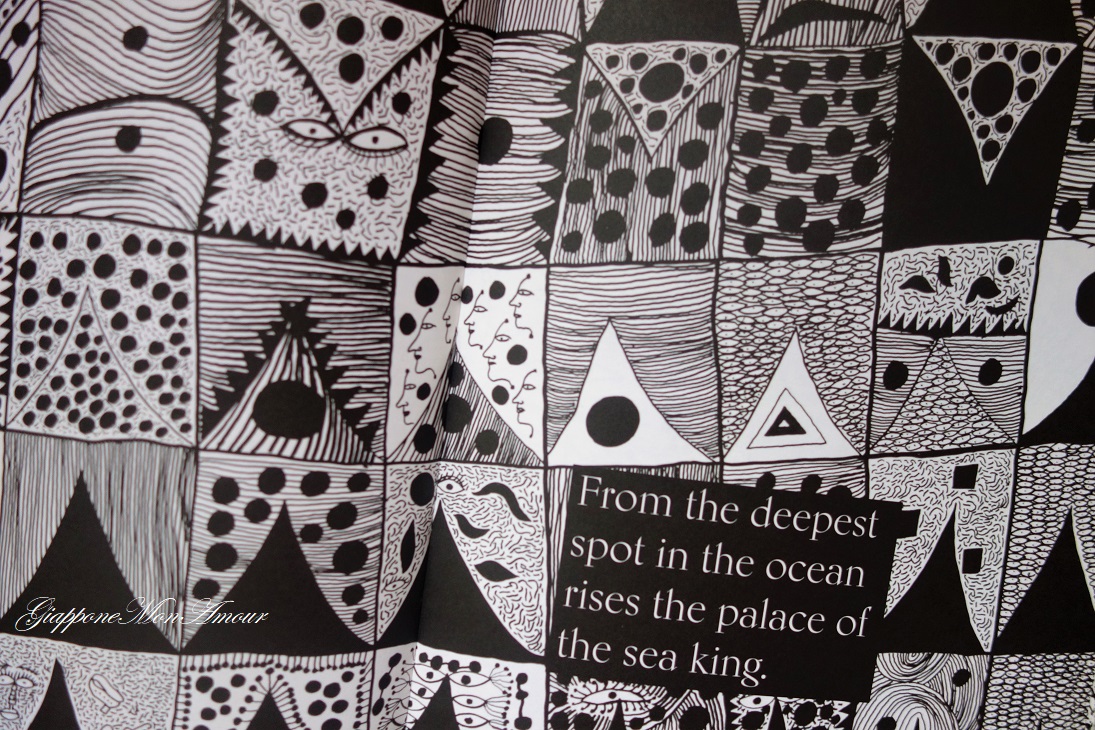「見えなくなること」 o delle cose che non vediamo più
“Ecco come sono le parole, nascondono molto, si uniscono pian piano fra di loro, sembra non sappiano dove vogliono andare, e all’improvviso, […] ecco lì che ci ritroviamo la commozione che sale irresistibilmente alla superficie della pelle e degli occhi, che incrina la compostezza dei sentimenti”
José Saramago, Cecità
Non ricordo quanti anni avevo, abbastanza comunque da non far correre via la memoria. Dovevo essere però alle elementari, perché nella mia mano c’erano strette le dita nervose di mamma.
 Eravamo a Piazza Bologna, dirette o forse di ritorno da quella che un tempo era la SMA, c’era anche mia sorella. Amavo infilare la moneta da 500 lire nel tondo del carrello, liberare la catenella, osservare alla cassa il nastro che scorreva sempre troppo veloce e cercare di accordarmi a quel movimento; e poi i ripiani rimpinzati di tinte squillanti, desideri mai esauditi di cioccolate, pacchi sgargianti di gelati confezionati, merendine che mia madre, tuttavia, non ci comprava.
Eravamo a Piazza Bologna, dirette o forse di ritorno da quella che un tempo era la SMA, c’era anche mia sorella. Amavo infilare la moneta da 500 lire nel tondo del carrello, liberare la catenella, osservare alla cassa il nastro che scorreva sempre troppo veloce e cercare di accordarmi a quel movimento; e poi i ripiani rimpinzati di tinte squillanti, desideri mai esauditi di cioccolate, pacchi sgargianti di gelati confezionati, merendine che mia madre, tuttavia, non ci comprava.
Preparava invece ciambelloni al limone, al cioccolato, alla vaniglia, che sono tutto il ricordo delle mie colazioni di bambina, torte che non avevano un buco in mezzo e che quindi, mi chiedo in ritardo di un ventennio, perché mai si chiamavano così? Ma la vita, quando la si vive, la si accetta così. Proprio com’è.
 Ebbene, c’era un barbone steso su un lembo di strada, obliquo come su un triclinio oppure seduto, su una rientranza del muro che cingeva una banca. Mi pare, soltanto, perché lì l’immagine si fa nebulosa.
Ebbene, c’era un barbone steso su un lembo di strada, obliquo come su un triclinio oppure seduto, su una rientranza del muro che cingeva una banca. Mi pare, soltanto, perché lì l’immagine si fa nebulosa.
Ricordo tuttavia con una nettezza incredibilmente precisa – proprio io che non archivio nulla per paura di rimestare certe zone d’ombra dell’infanzia – la pena che provai per quell’uomo e la vergogna, sì la vergogna, nel chiedere a mia mamma di porgergli una moneta.
I due sentimenti, nella frizione, produssero una menzogna.
Feci un commento goffo, sulla pavimentazione, pronunciai qualcosa di sciocco per dissimulare la commozione e insieme per guidare l’attenzione di mia mamma sull’uomo, in quel modo intuitivo che da una soglia conduce a un ingresso e poi al ventre di una casa.
Mia madre però, che sciocca non era, forse si stizzì della bugia e, in quel modo troppo diretto che ho ereditato da lei, quel voler dimostrare all’altro di avere capito, quasi che tutti si attendessero da me solo stupidità, mi disse: “Basta che lo dici che vuoi fare l’elemosina. Ti do una moneta? Dai, vagliela a dare”
Sopraffatta dalla vergogna, scoperta, sbucciata della mia scorza che proprio in quegli anni si andava inspessendo, negai. La moneta non la raccolsi, né la ricollocai nel piattino esibito dall’uomo. E so che non fu per ingenerosità che mia madre non fece il gesto per prima: ha speso una vita nel volontariato, nella carità “seria”, che sistema le gambe di chi è caduto anziché metterlo su un solo momento, godersi la gratitudine, ma vederlo ricadere giù, subito dopo.
Il punto è un altro però. È che abituiamo i bambini alla cecità, scrive Mariapia Veladiano, a questa condizione che è indotta, e ci porta a deviare lo sguardo «tanto non puoi fare niente, sii prudente, potrebbe essere un imbroglio, magari un falso povero…» (Rigotti F. e Mariapia Veladiano, Venire al mondo, Trento, il Margine, 2015, p. 49).
 Eppure in ognuno permane una traccia di quanto eravamo, un calco di gesti primordiali dovuti, io credo, alla tenerezza che ricevemmo e che assorbimmo come acqua le piante. Quanto non ci è stato donato, non saremo purtroppo in grado di suggerirlo, così come è necessario sperimentare la tenerezza per non percepirla come un rischio, ricordarne la serica sensazione sulla pelle, il corpo che ci sostiene e abbraccia nonostante ogni fastidio.
Eppure in ognuno permane una traccia di quanto eravamo, un calco di gesti primordiali dovuti, io credo, alla tenerezza che ricevemmo e che assorbimmo come acqua le piante. Quanto non ci è stato donato, non saremo purtroppo in grado di suggerirlo, così come è necessario sperimentare la tenerezza per non percepirla come un rischio, ricordarne la serica sensazione sulla pelle, il corpo che ci sostiene e abbraccia nonostante ogni fastidio.
Se amiamo, se ne siamo in grado, è perché qualcuno ci ha amato e ce lo ha fatto sapere. Ci ha convinto ne fossimo degni, che quell’amore, spaesato, magari improduttivo, persino nocivo, ci appartenesse di diritto.
Così con la compassione, che sono convinta germogli nell’animo di chi ha patito e ricevuto in cambio non una strigliata, bensì una carezza.
La cecità, dicevamo. È vero che con i bambini creiamo deviazioni, io stessa già le metto in atto con Sousuke. Quando gli dico ad esempio degli animali – privati, come scriveva Berger, della loro vera natura, per essere trasfigurati da noi e diventare interlocutori antropomorfizzati cui tuttavia sappiamo soltanto parlar sopra – ecco che svio, sorvolo sul fatto che al gallo chicchirichì mozziamo la testa, che il maiale sgrunf sgrunf lo appendiamo a un gancio, che il vitello o l’agnello li sgozziamo quando altro non sono che bebè. E non è solo una questione di animali, ma di fette di popolazione cui dedichiamo una sterilizzata pietà e niente di più, sono alberi che vengono tagliati per far spazio a un parcheggio, di cose fabbricate e vendute solo perché durino poco e le si possa presto sostituire.

È lui che proteggo dalla verità? È lui veramente? Oppure è il mondo iniquo che ci circonda e di cui anch’io sorreggo complice una colonna?
Risetto, riformulo. No, non è colpa mia. Mi giustifico. In fondo faccio del mio meglio, cerco perlomeno d’essere sincera. Ma la sincerità è qualcosa che basta?
Di tutto questo grumo emotivo che nasce dalla cecità imposta ai bambini, del ricordo del barbone cui volevo donare una moneta, riflessioni nate sul treno, mentre la mattina mi dirigo all’università per vedere con i ragazzi un film, e al ritorno, ritardato da un suicidio sulla linea, mi restano essenzialmente due cose.
 Una è il pensiero che da almeno venticinque anni non tengo per mano mia mamma, che lei non tiene la mia. Che l’unica volta che accadde in età adulta, sulla via sterrata che conduceva al recinto del tempio di Kamakura Hachimangu, chiusa in un faticoso e lindo kimono, lì dove mi sarei unita in matrimonio a Ryosuke, e lì dove il passo si faceva esitante crocchiando sui ciottoli bianchi con i geta ai piedi, la ricordo con commozione. Uno dei ricordi più dolci che di mia madre conserverò.
Una è il pensiero che da almeno venticinque anni non tengo per mano mia mamma, che lei non tiene la mia. Che l’unica volta che accadde in età adulta, sulla via sterrata che conduceva al recinto del tempio di Kamakura Hachimangu, chiusa in un faticoso e lindo kimono, lì dove mi sarei unita in matrimonio a Ryosuke, e lì dove il passo si faceva esitante crocchiando sui ciottoli bianchi con i geta ai piedi, la ricordo con commozione. Uno dei ricordi più dolci che di mia madre conserverò.
E la seconda, per cui se è vero come scriveva Hannah Arendt (e nelle sue parole Sant’Agostino) che «con la nascita di ogni uomo si riafferma l’inizio originario, in quanto ogni nascita introduce qualcosa di nuovo in un mondo preesistente (e) proprio in quanto è un inizio, l’uomo può dare inizio a cose nuove» (ibid. p. 28), se davvero insomma ogni uomo o donna che nasce rimette in discussione tutto il percorso, azzera in parte quanto è stato costruito fino ad allora, e che quindi le occasioni che ci sono date dalla vita sono almeno due – quando si è guidati da un genitore, e quando genitore lo si diventa, e a propria volta si sceglie come guidare – allora la domanda da porsi è ora all’inverso:
«Mi salveranno i miei figli dalla cecità?»