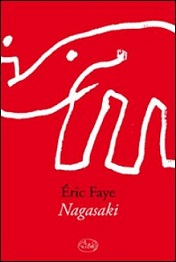L’Ufficio Postale del Futuro
Se esistesse un servizio di posta dilazionato nel tempo. Se scrivessi una lettera con la promessa che ti sarà recapitata un anno più tardi.
〒 Cosa sceglieresti di dirti?
〒 Cosa sceglieresti invece di non dirti?
〒 Userai parole semplici, quotidiane per raccontarti? Oppure scalerai i massimi sistemi, andrai dritta alle grandi emozioni?
 Scriverai a te o a qualcuno che ami? O magari a qualcuno che non sai se tra un anno sarà ancora nella tua vita?
Scriverai a te o a qualcuno che ami? O magari a qualcuno che non sai se tra un anno sarà ancora nella tua vita?
Sei sicuro che abiterai la stessa casa?
E se così non sarà, chi credi leggerà quella lettera quanto ti sei scritto?
Durante il viaggio in Hokkaido – di cui ci resta ancora addosso forte l’eco – abbiamo scoperto un angolo della ryokan che parlava di posta e di futuro, per l’esattezza Mirai yūbinkyoku 未来郵便局.
Ho letto con quella fame tipica della scoperta (e della meraviglia che sempre l’insegue) ogni riga scritta intorno alla futuristica cassetta postale, sui toni del bianco e dell’azzurro.
Ecco allora che Mirai yūbinkyoku 未来郵便局 è un servizio creato da un privato (Yoshiaki Kaihatsu) che, in dieci zone del Giappone, in certi periodi precisi, offre la possibilità di spedire una lettera che verrà tuttavia recapitata dopo un intero anno. Il servizio costa 200 yen, ed è comprensivo della carta da lettere, un cartoncino blu intenso, la busta, il francobollo già apposto.
Cercando in rete ho tuttavia scoperto come in Giappone esista un altro servizio attivo tutto l’anno e su tutto il territorio, che custodisce lettere e capsule del tempo fino a cinque o dieci anni. Cartoline, lettere e veri e propri pacchetti pieni di tesori di quel tempo preciso che si vuol ricordare, alla maniera di quel gioco che è tanto diffuso in questo paese e che ho ritrovato spesso nei film, nei libri e nei manga giapponesi, ovvero la creazione di capsule che venivano poi seppellite in giardino, o in un parco, in luoghi che si credeva sicuri e, in qualche modo, eterni.
Spesso capita che i protagonisti – in momenti particolarmente critici della loro vita – rinvengano per caso quelle capsule, e si accorgano di quanto il tempo li ha allontanati dalle cose importanti, dagli affetti, da una semplicità del vivere che si perde spesso crescendo. Quell’incontro con i se stessi del passato, di solito stravolge la trama, rimette moralmente in sesto i protagonisti dopo averli stravolti ben bene emotivamente.
Del resto, per capire quanto questo gioco col tempo sia profondo nell’immaginario di questo paese, basta inserire le parole chiave su google per veder sbocciare non una ma più aziende che si occupano di questo stesso desiderio di comunicare con un sé del futuro o con una persona importante.

Noi, quel giorno a Shiretoko, di lettere ne abbiamo comprate tre.
E sul tatami della ryokan, poco prima di partire per la destinazione successiva e lasciare la stanza, ci siamo seduti, il tavolino basso davanti. Eravamo accanto ma nessuno ha detto nulla nè ha sbirciato le parole dell’altro.
Perché Ryosuke mi ha scritto. E io ho scritto a lui.
Quando ho finito, però, ho scritto una seconda lettera, questa volta destinata a me stessa. Non posso dire cosa mi sono scritta, perché serve io lo dimentichi per poterlo un giorno “sentire”.
Perché il gioco non è solo quello della previsione ma della forza che ha il tempo. Sapere che c’è stata – e quindi c’è sempre – una me stessa che ha pensato alla me che diventerò l’anno successivo, e quello dopo ancora. E così via.
Mi ha ribadito in qualche modo il concetto per cui siamo noi coloro che devono vegliare su noi stessi. Che serve considerarsi in terza persona per volersi più bene.
E scommetto che, anche se questo anno che viene fosse un disastro, sarà bello sapere che mi sono pensata con quell’affetto, che mi sono data ottimi consigli come Alice nel Paese delle Meraviglie, che forse non ne ho seguito nemmeno uno, ma che sono stata capace di volermi bene, di pensarmi con affetto. E quello, più di ogni altra cosa è importante.
Scriversi una lettera. Inviarla all’Ufficio Postale del Futuro. Aspettarsi. Poi dimenticarsi. Ricevere una lettera da qualcuno che non siamo più noi
Lasciare nel tempo parole per i noi che ogni giorno si sommano a strati fino a formarci, proprio come gli anelli nei tronchi degli alberi.
Ci ricorda quanto serva un po’ di distacco per acquistare oggettività su di sè. Che forse è la cosa più complicata in assoluto da ottenere.