Goro goro 1
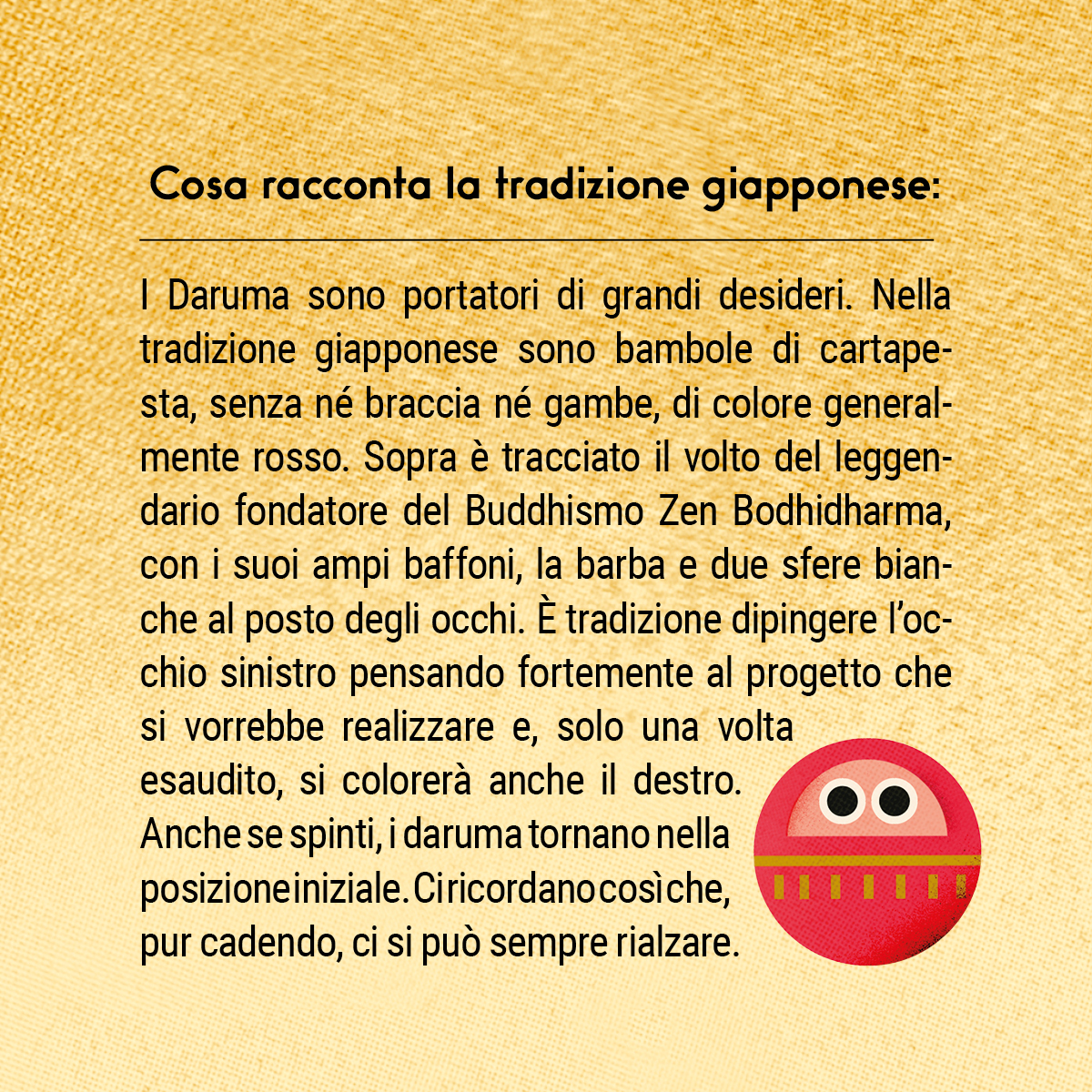

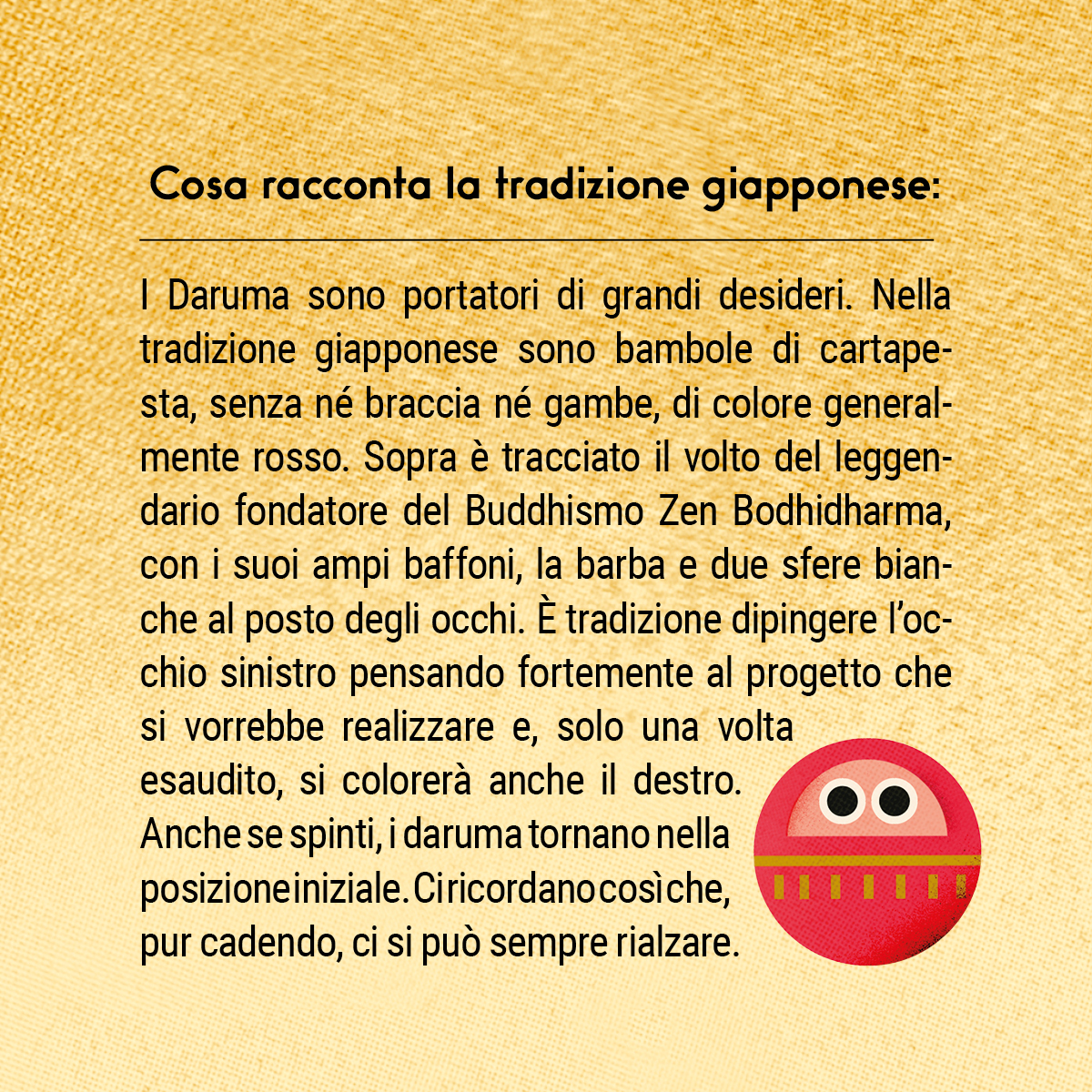
La storia migliore della mia giornata sono un anziano e una pallina.
L’anziano non lo conosco, la pallina era verde. E, a distanza di un giorno, ancora non conosco l’anziano e la pallina è sempre verde, forse un po’ più consumata di prima.
Stavo passeggiando per Kamakura in questo mercoledì di oceano e di sole, ascoltando voci, a mia volta registrando vocali fiume.
 Ed ecco questo anziano ingolfato per il freddo che procede lungo la strada, in una passeggiata che immagino quotidiana come quella della sottoscritta. Si ferma. Una pallina verde (quella) poco dentro la strada, ma di chiara appartenenza altra. Con la punta della scarpa l’ha spinta verso l’interno della rientranza – uno spazio dedicato probabilmente a parcheggiarvi una bicicletta. Ma il terreno era scosceso e, per quanto calciasse la sfera, quella tornava alla strada. E poi alla scarpa, che riprendeva a spintonarla, come un corpo a Tōkyō nella calca di un treno all’ora di punta, che oscilla e torna di peso su un altro e a intervalli ritorna.
Ed ecco questo anziano ingolfato per il freddo che procede lungo la strada, in una passeggiata che immagino quotidiana come quella della sottoscritta. Si ferma. Una pallina verde (quella) poco dentro la strada, ma di chiara appartenenza altra. Con la punta della scarpa l’ha spinta verso l’interno della rientranza – uno spazio dedicato probabilmente a parcheggiarvi una bicicletta. Ma il terreno era scosceso e, per quanto calciasse la sfera, quella tornava alla strada. E poi alla scarpa, che riprendeva a spintonarla, come un corpo a Tōkyō nella calca di un treno all’ora di punta, che oscilla e torna di peso su un altro e a intervalli ritorna.
Il movimento dell’anziano si è fatto vivace. L’occhio pure. C’era l’attesa, mi è parso, che tornasse la pallina alla strada e che lui la potesse colpire di nuovo.
L’ho fotografato di spalle, per non cancellarne la memoria. E girandomi a guardarlo, a intermezzi sempre più ampi, finché non si è curvata la strada, era ancora lì. Ad avere a che fare con la pallina e la sua attesa.
Era bello da vedere. Il bambino che sale. Come un cibo non digerito, che torna (piacevolmente) su nel sapore.
Spesso mi domando cosa succeda quando si dismetta la fretta. Quando si sia già vissuta la vita nel modo in cui si intende la vita, ovvero gli impegni, il mirare ansioso e ingordo verso qualcosa. Mi domando se non sia saggio, prima di invecchiare, iniziare a dedicarsi porzioni di vita senza obiettivo.
Fare dell’inutile una quota del giorno, scoprire come sia abitare il corpo, guardare il mondo – senza volerlo possedere neanche per errore.
Altrimenti, a pensarci, del tempo mi viene paura.