Di gennaio o del valore di insegnare
 Gennaio è il primo mese. E l’ultimo in molte università.
Gennaio è il primo mese. E l’ultimo in molte università.
L’anno lo si coniuga a seconda del tracciato che si segue e così, per me, questo mese in cui le temperature si irrigidiscono, in cui la Cerimonia della Maggiore Età veste di sgargianti kimono le ventenni giapponesi e ogni cosa è la prima cosa (初詣、初・・・ in un gioco di inizio anno che elenca tutte le azioni che si compiono per la prima volta), è la conclusione di un anno di lavoro che si inaugura in aprile con lo sbocciare dei ciliegi e sfocia nel termometro che segna – 1°C e, talvolta, nella neve.
Ed ogni volta che qualcosa si conclude, rifletto sul valore di ciò che sto facendo. Mi accerto della fortuna che ho nel non provare vera fatica nel lavoro. Penso ai ragazzi. Penso al significato di insegnare.
Prima degli esami, due a due, incontro gli studenti ed è occasione di parola, luogo seppur stretto e un poco angusto in cui raccontarsi. Scopro che c’è chi disegna manga, partecipa il martedì e il venerdì al club di fumetti dell’università, eppure vorrebbe diventare curatrice di musei. Chi mi mostra uno scatto che la ritrae in kimono per la festa dei vent’anni, accanto il volto fiero di suo padre e di sua madre. Chi gioca a football americano e spera di farne una carriera. Chi vuole diventare insegnante di scuola elementare. Chi sogna di fare il giro del mondo e di fermarsi in Italia. Che del nostro paese vede in primo piano il meglio che, della sua bellezza, sa inglobare e mitigare ogni asprezza.
 Esiste un termine orrendo, spesso sfruttato da chi parla di Giappone, ovvero “giappominchia” o, con diversa trascrizione, “jappominkia”. Al di là della superficialità d’un approccio alla cultura giapponese – che di per sè già non costituisce alcun reato – non vi è, mi sembra, altro disturbo se non quello di trovarsi di fronte ad un amore incondizionato per aspetti d’una cultura conosciuta in modo indubbiamente parziale e superficiale. Caratteristiche ideali che poi hanno naturalmente contagiato la visione tutta di quel luogo.
Esiste un termine orrendo, spesso sfruttato da chi parla di Giappone, ovvero “giappominchia” o, con diversa trascrizione, “jappominkia”. Al di là della superficialità d’un approccio alla cultura giapponese – che di per sè già non costituisce alcun reato – non vi è, mi sembra, altro disturbo se non quello di trovarsi di fronte ad un amore incondizionato per aspetti d’una cultura conosciuta in modo indubbiamente parziale e superficiale. Caratteristiche ideali che poi hanno naturalmente contagiato la visione tutta di quel luogo.
Eppure, a meno che non si metta in moto quel fastidioso meccanismo secondo cui per amare qualcosa sia necessario disprezzarne un’altra (vedi il penoso e sterile confronto tra l’Italia e il Giappone, tra la realtà a sè più prossima e quella invece impalpabile e lontana), non trovo nell’amore frivolo un crimine. Semmai una debolezza o una limitazione.
 L’autodenigrazione, adorato vizio di noi italiani, e la denigrazione, altra faccia della medesima medaglia, le trovo invece decisamente deprecabili.
L’autodenigrazione, adorato vizio di noi italiani, e la denigrazione, altra faccia della medesima medaglia, le trovo invece decisamente deprecabili.
Chi vuole informarsi troverà sempre strada tra le pagine di un libro. Chi non vuole, resterà invece esattamente dove è, con desiderio nullo di spostarsi. Scelte, a mio parere. Non condivisibili per forza, ma scelte.
Noto però frequentemente, e con stupore, una rabbia smisurata da parte di chi avverte nella propria conoscenza della materia (in questo caso quella giapponese) una superiorità tale da poter e dover giudicare chi ne ha anche solo poca meno. Che fa dell’aver appreso, un’arma da sfruttare in modo improprio. Eppure mi chiedo: è un argomento esauribile il Giappone? Quanto di personale c’è in ogni punto di vista su questo paese?
 E mi viene da pensare come insegnare, se si decide di farlo veramente, deve contenere in chi s’erge a maestro, l’eventualità di non essere ascoltato. Insegnare non è un’imposizione ma si nutre della scelta di chi impara.
E mi viene da pensare come insegnare, se si decide di farlo veramente, deve contenere in chi s’erge a maestro, l’eventualità di non essere ascoltato. Insegnare non è un’imposizione ma si nutre della scelta di chi impara.
E se non si è disposti ad essere gentili, a relazionarsi con garbo e a smentire o confutare con delicatezza, ci si deve esimere dal dire. Che non è insegnare quello, ma schiacciare per imporre la (spesso poca) conoscenza che si ha.
Insegnare è un’altra cosa. E se lo si vuole fare, ci si deve ricordare di quanto si è faticato, di quanta gioia serva ad imparare.
Credo d’averlo appreso nella pratica, nella frequentazione quotidiana con l’ambiente universitario, sia in veste di docente che in quello di studente. In bilico tra i due ruoli, mi sono trovata ad imparare maggiormente da chi non usava violenza nel linguaggio, ad esercitare il potere della propria posizione. L’autorità intellettuale sfrutta toni pacati, è forte del proprio sapere. Non sente la necessità di gridare od insultare.
Insegnare ad imparare è la prima cosa, prima ancora del ripieno, dell’involto che ci si prepara a consegnare. È la sfoglia, la consistenza della pasta.
Imparare non è mai facile. É creare spazi in una mente già affollata da altre cose, da una vita quotidiana spesso assillata da urgenze e preoccupazioni. Serve gioia, serve gentilezza. Non bisogna mai causare umiliazione nè senso di inferiorità. Perchè lì si rischia di procurare una ferita e raramente si torna a toccare una zona offesa, dolorante.
In giapponese si dice 「褒めて伸ばす」 /homete nobasu/ ovvero “far crescere lodando”. Non è quindi sgridando o punendo che si riesce a far sviluppare le capacità e l’intelletto di qualcuno, bensì evidenziandone i meriti e le abilità.
Ed è così, con questo amore ed apprezzamento per chi si ha davanti, virtualmente o in carne ed ossa, che si dovrebbe donare quello che si sa.





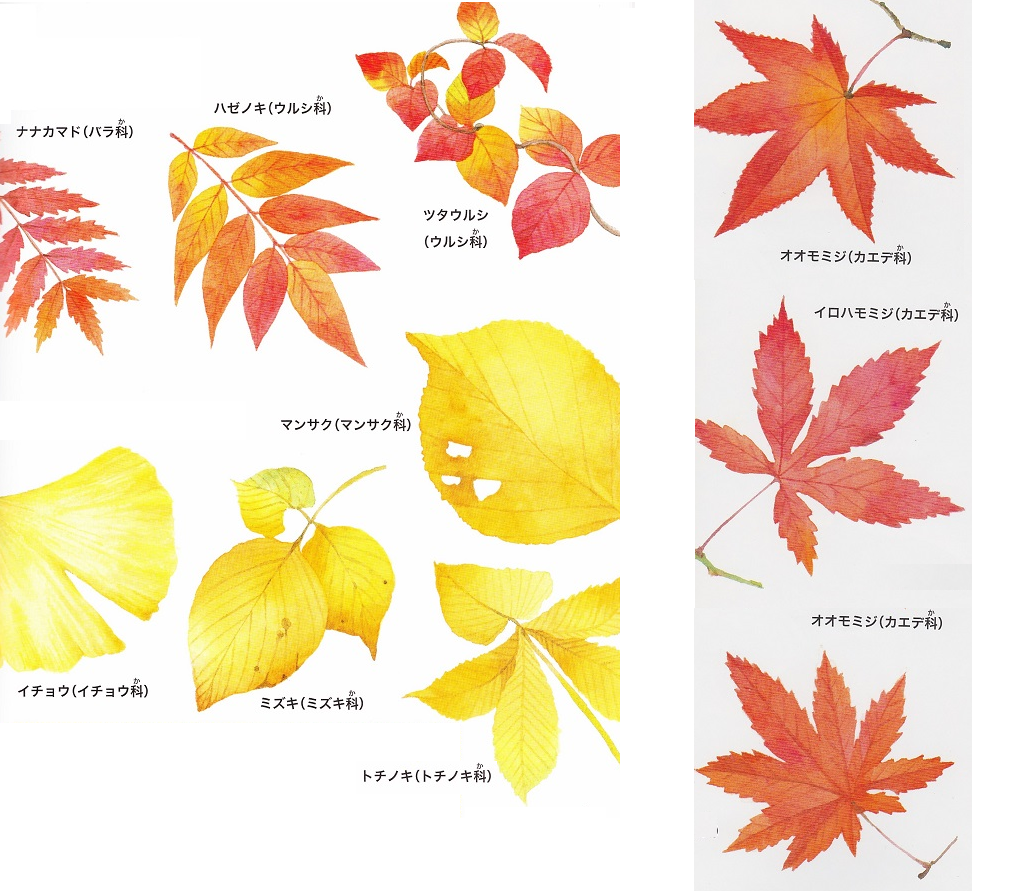







 In alto a sinistra c’è 「立つ」 /tatsu/ stare in piedi, alzarsi, sotto c’è 「木」 /ki/ l’albero e a destra c’è 「見る」 /miru/ vedere, guardare.
In alto a sinistra c’è 「立つ」 /tatsu/ stare in piedi, alzarsi, sotto c’è 「木」 /ki/ l’albero e a destra c’è 「見る」 /miru/ vedere, guardare.






