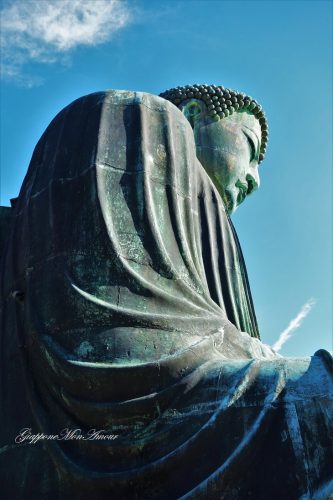Vi racconto mia figlia
Ho immaginato da principio tre città, che fossero Roma, Tōkyō e Parigi. Le ho viste fondersi nei lineamenti, divenire una sorta di ‘Rotopa’ o ‘Makyogi’, un ibrido che desse vita a un pasticcio emozionale in cui personaggi di diverse culture e derivazioni si trovassero a rappresentarsi in quella caccia alle farfalle che è la felicità. Li ho immaginati venire a compromesso con la vita, nel loro modo singolare, collidere gli uni contro gli altri, e dare origine a sentimenti che non li lasciano illesi.
Parigi è rimasta, ma come un filone francese, che molto suggerisce dei nomi. Roma è confluita in Tōkyō, e Tōkyō in Roma.
E Clara, che è così calata dentro il proprio mondo interiore, dà alle strade i nomi dei propri pensieri mentre le percorre. Via del Burro da Comprare, Viale del Batticuore, Via della Fuga dal Padre.
 Investigare la gioia mi ha quasi turbato: l’ho sempre pretesa ma senza saperne il significato.
Investigare la gioia mi ha quasi turbato: l’ho sempre pretesa ma senza saperne il significato.
Esiste in Giappone un particolare tipo di fuoco d’artificio, si chiama「線香花火」/senkō hanabi/, un sottilissimo filo cui è attaccata una sorta di capocchia che accesa, dopo aver brillato di nervature intense e irregolari, precipita a terra, mettendo fine al gioco. Tutto sta nel tenere quanto più salda e immobile la mano, per far sì da prolungare la fiamma.
Ecco, la gioia è un fascio di minuscoli lampi nell’oscurità, la brevità intensissima di un’esperienza; ma è anche impegno, volontà, concentrazione. È un costante esercizio di manutenzione delle proprie emozioni, un’educazione sentimentale che ci portiamo dietro tutta la vita.
 Mi viene spesso chiesto quanto sia contata nella scrittura la mia esperienza personale, di madre cercata, non realizzata, poi successa, ottenuta, rielaborata.
Mi viene spesso chiesto quanto sia contata nella scrittura la mia esperienza personale, di madre cercata, non realizzata, poi successa, ottenuta, rielaborata.
È una prova immensa l’infertilità, così come la perdita di un figlio, in qualunque fase di sviluppo accada. Muore un’idea, un progetto di vita. E la gioia, che è soprattutto immaginazione, ne è per forza di cose compromessa.
La maternità stessa è una cosa immensa eppure fragilissima, così poco incline a piegarsi alla realtà dei fatti. Per dire, la gravidanza è una cosa, la maternità un’altra, e questa va oltretutto declinata all’età del bambino, alle circostanze, perché essere madri di un feto, di un bambino di due anni, di uno di cinque, o di dieci, in una città o un’altra, con un lavoro, un marito, una famiglia o meno, è di volta in volta una cosa diversa.
Si tratta di una condizione di instabilità e insieme di emotività intensissima che a mio parere riesce quindi a descrivere bene quella cosa complicatissima e articolata che è la gioia.
Quando penso a Clara mi torna in mente sempre una frase che lessi molti anni fa. 「置かれた場所で咲きなさい」“Dove sei stato posato fiorisci”, titolo di un delicatissimo libro di Watanabe Kazuko. Lo credo fermamente. Ed ecco un’altra radice del libro, “la felicità nonostante”.
E se a qualcosa serve la letteratura è a sviluppare empatia nei confronti del mondo, quello più prossimo e luccicante, e quello che pare aggredire tanto è in difficoltà.
L’altro è il Giappone, ma anche un altro distinto, che ogni individuo si porta addosso il proprio universo, attaccato alla schiena come una conchiglia. E talvolta vi si ritrae pure dentro, impaurito.
Forse è per questo che i miei romanzi sono sempre assai popolati, e le storie, d’inizio divise, si vanno mischiando fino a bruciarsi l’una nell’altra come falene sul fuoco.

Ed è sempre per questo che i finali sono importanti, che ho distribuito una porzione di gioia a tutti, che l’intreccio è colmo di colpi di scena, studiati negli anni come naturalmente destinati a svilupparsi così. Esattamente così.
C’è una frase di Stevenson in cui mi sono imbattuta di recente e che avrei probabilmente inserito in epigrafe, tra le tante che ho posto come una spilla sul petto di ogni capitolo, a battere il ritmo del libro: “Non esiste alcun dovere tanto sottovalutato quanto l’esser felici”.
Ecco, vivere al meglio è innanzitutto un esercizio di volontà, qualcosa per cui dobbiamo (dobbiamo!) affilare tutti i nostri strumenti.
Credo questo romanzo spieghi che la gioia è una intenzione innanzitutto, una scelta. Che tuttavia non c’è nulla da meritarsi e che spesso le cose migliori arrivano senza diretta conseguenza dei nostri atti. Il tempo passa comunque, per tutti, e spesso ripara, e la vita che ci è stata data, dipende nella maturità in gran parte da noi. Insomma, si può davvero essere felici, non è una chimera, da qualunque punto si parta.
 Ed io? Ecco, io vorrei avere l’allegria disinvolta di Momoko, il suo esser fuori contesto e proprio per questo rendersi in grado di cambiare la vita degli altri in meglio, la generosa bontà di Marcel, la consapevolezza profonda di Jean.
Ed io? Ecco, io vorrei avere l’allegria disinvolta di Momoko, il suo esser fuori contesto e proprio per questo rendersi in grado di cambiare la vita degli altri in meglio, la generosa bontà di Marcel, la consapevolezza profonda di Jean.
Credo di riconoscermi in Clara, per via del suo controllo maniacale, della tenacia e del perfezionismo che esercita nella speranza di rendere il mondo intorno a lei più riconoscibile, per l’ossessione che ha di salvarsi da un’emotività che spesso la schiaccia, e insieme per il fascino immenso che malgrado tutto prova per la vita che la circonda e di cui vorrebbe tanto far parte.
Come ho già scritto più volte sono arrivata io stessa alla maternità dopo una dolente odissea, e Non oso dire la gioia l’ho scritto nei circa tre anni che corrispondono alle mie cure contro l’infertilità – esperienza che mi ha spiegato come in certi ambiti non esista corrispondenza alcuna tra l’impegno e il risultato (cosa sconvolgente per me, che ho sempre sentito di dovermi meritare tutto quanto di bello cui ambivo, come se una felicità immeritata fosse instabile, insicura), a quello che mi fu annunciato come un aborto, alla prima difficile gravidanza, alla nascita di mio figlio Sōsuke, a un nuovo ciclo di cure e alla seconda gravidanza che mi ha reso ancora madre a luglio 2017. Due maschietti.
Ecco, so per certo che se mi fosse nata una figlia l’avrei chiamata Gioia.