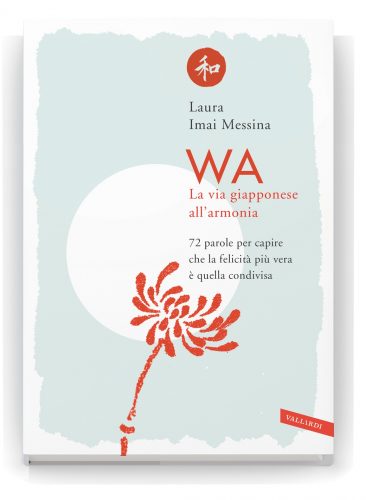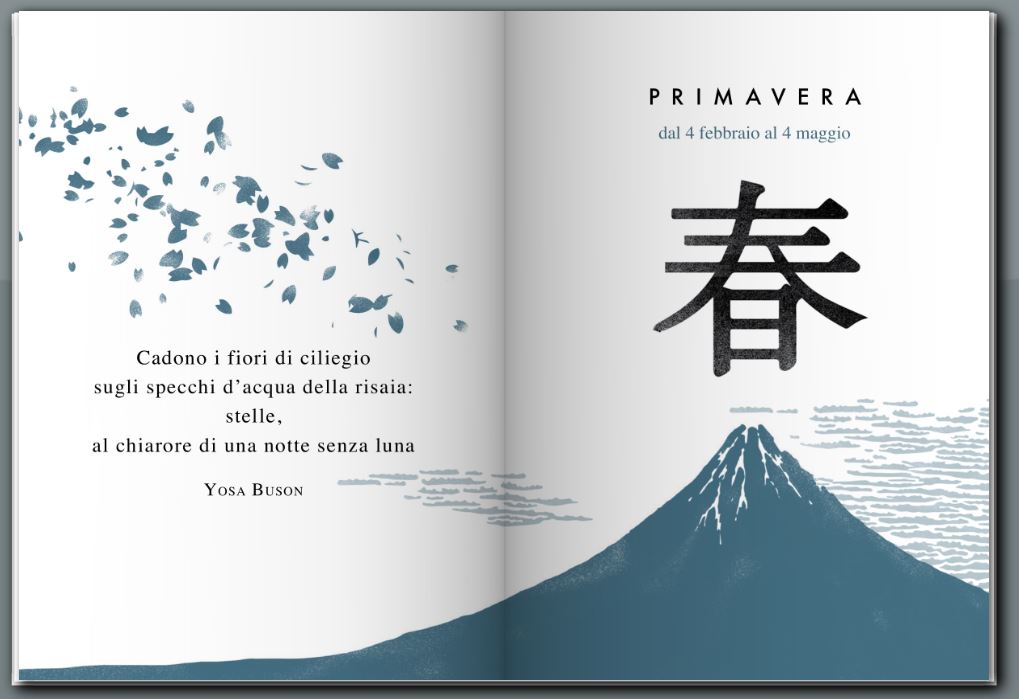«È l’ultimo giorno, è l’ultima volta»
一期一会 ichi-go ichi-e
«Una volta, un incontro»

Questa mano che si allinea al cellulare, lo scansa.
La tazza di maccha macchiata di saliva. La briciola d’oro che tocca le labbra.
Entro in un caffè con mio figlio. Lui ha tre anni, lui pretende un kakigori fuori stagione. Lui pretende innanzitutto che la gioia arrivi ogni giorno, in ogni momento, senza recinzioni. Il kakigori, nello specifico, è colpa di un bel ricordo cucito sulla pelle dell’estate, insieme con la madre e il padre. Con Ryōsuke e con me.
Trovo sul bordo della tazza la sbreccatura riparata con l’arte del kintsugi, la ferita che si fa bellezza d’aggiunta.
Eccomi, sono in Giappone, non faccio che dimenticarlo. Questa è “solo” la mia bellissima casa.
「今日は最後だ」
«È l’ultimo giorno»
一期一会 ichi-go ichi-e
«Una volta, un incontro»

La mattina la sveglia, in questo budello di mondo che si chiama Giappone, prima che l’alba alzi la mano, dichiari la sua presenza. Esco nel buio, l’autunno che avanza come un soldato in licenza.
E anche il treno è affollato, la gente straripa.
La Yamanote che da Ikebukuro s’alza e corre di filato verso la prossima tappa, mi ricorda i giri in tondo che facevo appena arrivata. Avevo vent’anni più un quarto, meno due, meno uno. Volevo vedere tutto, ero affamata di vita. Ero ingorda di Tōkyō.
Da Shin-Okubo, il quartiere coreano, la Yamanote pare spiccare il volo e incanalandosi a velocità sostenuta – ma rallentata verso la banchina – a sinistra dà l’impressione di scontrarsi con la Linea Sōbu, quella gialla, che si affianca, con i medesimi finestroni trasparenti, la gente basculante e appesa come tanti piccoli okiagari-koboshi.
「今日は最後だ。最後の人生だ。」
«Oggi è l’ultimo giorno, è l’ultima vita. È l’ultima volta»
一期一会 ichi-go ichi-e
«Una volta, un incontro»
 Il vicino si muove troppo, fatico a concentrarmi nella scrittura. Pare irrequieto, fruga nervosamente nella sacca, i gomiti s’alzano come ali. In un attimo mi torna in mente Sōsuke che nell’o-furo solleva una gambetta, la piega, poggia la pianta sul ginocchio a formare un triangolo altamente imperfetto.
Il vicino si muove troppo, fatico a concentrarmi nella scrittura. Pare irrequieto, fruga nervosamente nella sacca, i gomiti s’alzano come ali. In un attimo mi torna in mente Sōsuke che nell’o-furo solleva una gambetta, la piega, poggia la pianta sul ginocchio a formare un triangolo altamente imperfetto.
«Sōsuke è un fenicottero» esclamava radioso, in quella sua terza persona da bimbo che il sé lo distanzia, ne fa l’oggetto di osservazione. Lo studia.
Ho poco tempo, devo concludere questo trancio di scrittura per stasera o non rientro nella mia personale scadenza. Chi pensa che scrivere libri sia una passeggiata si sbaglia. Bisogna leggere dieci volte quanto si scrive, richiede tempo che per principio non si ha. Dargli la priorità fa sentire in colpa. Eppure ogni giorno mi sveglio alle 4.44, anche oggi, solo per questo.
L’uomo che mi è seduto accanto però, ancora e ancora una volta, mi urta il braccio. Perdo la concentrazione, rinuncio.
«È l’ultimo giorno, è l’ultima volta che sali qui, l’ultima volta che viaggi sulla Yamanote, l’ultima volta che potrai sederti su un treno. L’ultima e basta»
Saigo da, saigo da yo!
Pare una nenia, mi annega la testa.

Ed ecco che alzando gli occhi – perché è l’ultima volta, me ne convinco – scopro una figura di donna, delle più stupefacenti. Mi era di fronte e non l’avrei mai notata se non avessi dovuto staccare lo sguardo dalla mia vita per spostarmi su quella degli altri. Più valevole di qualunque parola che avrei potuto scrivere allora, ritrovo nella donna un frammento del libro che stavo scrivendo. Rinvengo persino il raccordo tra la natura viva del mondo e quella virgola d’occhi e di bocca che mi si staglia davanti, Tōkyō che le sfreccia alle spalle, placida nella sua mattina di sole.
Quando il livello di intolleranza supera una certa soglia, la realtà va circoscritta.
Ed ecco il mio personale sistema, sviluppato da un anno circa.
«È l’ultimo giorno» mi dico, anzi me ne persuado. Calo nel personaggio, in quello di qualcuno che abbia una esistenza sradicata dai luoghi, dalle persone, che sia errante e non abbia la possibilità concreta di ritorni. Nell’immaginare quell’ultima volta cambia un po’ tutto.
 Ecco allora che nessuna vita più mi trattiene. Sono rappresa su un cucchiaino, su un kanji, in una borsa, sfoglio un libro e ne lascio un pezzetto e penso che è per sempre, che niente tornerà più.
Ecco allora che nessuna vita più mi trattiene. Sono rappresa su un cucchiaino, su un kanji, in una borsa, sfoglio un libro e ne lascio un pezzetto e penso che è per sempre, che niente tornerà più.
Mi proteggo così dal nervosismo, dall’ira. Dal particolarismo del momento.
Il Maestro Dogen suggeriva si facesse ogni cosa come fosse la prima, ingerire piccolissimi bocconi di cibo, masticarli, assaporarli come li si stesse assaggiando non per l’ennesima, ma per la prima volta. E così Šklovskij e il senso di meraviglia, lo straniamento, la sorpresa, lo sconosciuto che la letteratura ripropone in qualche modo, grazie al fatto che distanzia i fatti che toccano tutti, ponendoli al di là di una vetrina, dove non si tocca. Serve a osservarli per bene, come, appunto, la prima volta.
Ci ho provato. Ho imparato la lezione. L’ho fatta mia.
Adesso però ne ho trovata una variante.
Io tento di partire dal fondo: che sia non la prima volta, ma l’ultima volta.
Al posto della meraviglia che richiede un inganno, uno sforzo di immaginarsi tabulae rasae – creature resettate, senza ricordo delle migliaia di volte in cui si è portato il cibo alla bocca, si è vista la luce inghiottita all’orizzonte, si è dato un bacio – nel piatto io butto la nostalgia di quanto è stato, proprio perché è stato, il ricordo, la malinconia che migliora ogni esperienza anche negativa che si è fatta ricordo.
一期一会 ichi-go ichi-e
«Una volta, un incontro»
Provare, funziona. Provare funziona.
 Il bambino prendeva tra le mani le lamelle di carta, ne studiava con scrupolosa attenzione il perimetro e i bordi, chiudeva un attimo gli occhi in una posa concentrata e poi, spalancandoli di botto, eccitato gridava: «È il Belgio!», «È la Thailandia!».
Il bambino prendeva tra le mani le lamelle di carta, ne studiava con scrupolosa attenzione il perimetro e i bordi, chiudeva un attimo gli occhi in una posa concentrata e poi, spalancandoli di botto, eccitato gridava: «È il Belgio!», «È la Thailandia!».