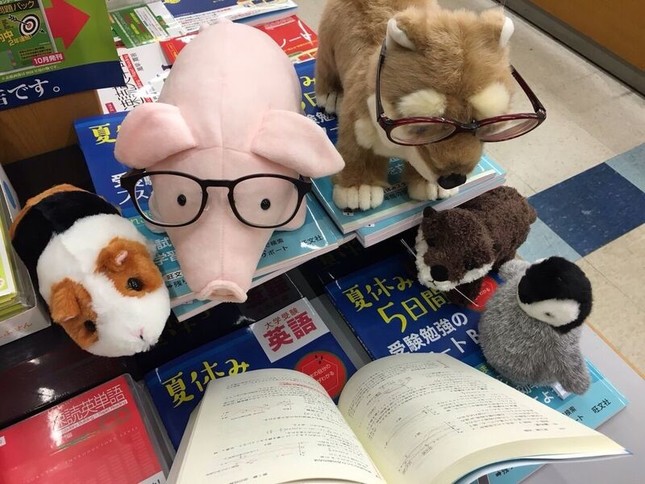Metà luce e metà buio. L’anno si spacca in due. Era il 30 di giugno. E da allora la luce è andata inesorabilmente diminuendo, ogni giorno di più.
Metà luce e metà buio. L’anno si spacca in due. Era il 30 di giugno. E da allora la luce è andata inesorabilmente diminuendo, ogni giorno di più.
Pioveva quel mese in modo irregolare, ma costantemente, nel colore quasi sempre grigio e bianco del cielo.
L’umidità saliva e sale ancora, il respiro nelle ore più calde si faceva faticoso. Ora è già autunno, l’estate arretra.
Quel giorno mi trovavo in treno, in un punto intermedio tra Shinjuku e Shibuya. La città mi sfrecciava a destra, le nuove costruzioni, le Olimpiadi che avanzano scavando con le dita nel corpo di Tōkyō.
Avevo finito di lavorare all’università, e nel prima e nel dopo di quello stacco pieno di ragazzi che mi pare ormai più una seconda vita, c’è sempre quel blocco compatto di lettura, pensiero, scrittura. Il computer sulle ginocchia, la musica in cuffia, più spesso una melodia che ripropone solo la pioggia. Rumore bianco che facilita il tuffo.
Ho sviluppato negli anni tecniche sottilissime e astute per trovare posto a sedere. Chiunque viva a Tōkyō e dintorni lo fa.
 Per dire, riconosco a prima vista movimenti accennati già in fila, riuscendo a intuire se è a destra o a sinistra che andranno le persone sulla banchina davanti a me, non appena si apriranno le portiere; ne capisco la tipologia, lo scatto in velocità verso il sedile più laterale, il movimento invece di chi preferisce salire nei convogli (di solito due per treno) che hanno l’aria condizionata meno forte. So persino l’orario e le stazioni in cui viene acceso il gettito d’aria, la mattina.
Per dire, riconosco a prima vista movimenti accennati già in fila, riuscendo a intuire se è a destra o a sinistra che andranno le persone sulla banchina davanti a me, non appena si apriranno le portiere; ne capisco la tipologia, lo scatto in velocità verso il sedile più laterale, il movimento invece di chi preferisce salire nei convogli (di solito due per treno) che hanno l’aria condizionata meno forte. So persino l’orario e le stazioni in cui viene acceso il gettito d’aria, la mattina.
Si è tutti abitudinari, tanto che a prendere il treno alla medesima ora si incontrano le stesse persone, ogni giorno; si sa in che momento tireranno fuori la bottiglietta di tè dalla borsa, se leggeranno il giornale, che genere di libri amano, se pongono sui portapacchi lo zaino oppure lo tengono stretto tra le braccia. Posso predire il momento in cui serreranno ogni cosa e si abbandoneranno al sonno.
So, per certo, dove scenderanno.

In questo contesto di precisione, al limite del maniacale, quel giorno in cui l’anno si spaccava in due, ho visto un uomo con un bastone. Era giovane, doveva essersi fatto male per una qualche ragione, non pareva avere familiarità con quella protesi. Appoggiato al finestrino, al lato della carrozza, era irrequieto, guardava verso i posti di priorità, ma nessuno vedeva lui.
Già dopo qualche anno di vita in Giappone, e a Tōkyō in particolare, ho capito una cosa. Ovvero che non è facile giudicare chi non si alza per cedere il posto.
La giornata che si porta sulle spalle quel qualcuno, solo quel qualcuno, la sa.
Una giovane donna con un ciclo dolorosissimo, per dire, un uomo che abbia appena subito una sfuriata da un capo. Un giovane uomo che abbia affrontato un’operazione, qualcosa che riguarda magari organi interni. O ancora, una madre in allattamento, con poche ore di sonno spezzate alle spalle. Una persona malata di depressione, che necessiti di riposo, seduta, anche solo per chiudere gli occhi e prendersi una pausa dalla sensazione avvilente che tutto mondo sia contro di lei.
Non è buonismo, ma gioco di immaginazione. E, la letteratura lo insegna, l’immaginazione spesso si avvicina alla realtà più della sua didascalica descrizione.
Metà luce e metà buio.

E tuttavia ci sono delle cose che ti danno sollievo immediato («me ne resto seduta, me lo merito, sono così stanca, quell’uomo neppure mi guarda») ma che sul lungo periodo ti fanno pentire.
Azioni che, a non farle, ti senti leggero. Ma dopo, nel ricordarle, scopri erano solo false-leggere, come certi cibi che paiono eterei (vedi la panna, certe bibite strapiene di zucchero, il cioccolato fuso) e poi hanno più calorie che una enorme ciotola di rāmen o un intero pollo fritto con le patate.
Certi atteggiamenti lasciano come un alone, il giallo di sudore che si forma sui vestiti bianchi sotto l’ascella.
E ti guastano tutto.
Non stavo scrivendo, lo ricordo. Perché quando scrivo sono risucchiata in quel mondo, romanzo o saggio che sia, e sono sì lucidissima nella mente, molto più di quanto non sia nel quotidiano, ma tuttavia poco presente. Ci sono ma non vedo niente.
Per questo ho individuato quel giovane uomo con il bastone, perché il computer era chiuso e io stavo “solo” leggendo.
Ho avuto un attimo di indecisione (da anni dormo niente la notte, mi sveglio alle 4.30 per scrivere, ho due bimbi minuscoli che assorbono ogni mio momento di pausa con le loro infinite richieste, la schiena a pezzi e una serie di malanni latenti etc. etc.). Ho pensato però che la sfiducia, al pari della fiducia, è un contagio. Che a non farlo sedere, quell’uomo si sarebbe portato a casa la sensazione d’esser poco considerato. Che in qualche modo avrebbe restituito quella emozione negativa a qualcuno, familiare o sconosciuto, quel giorno o il successivo.
 Ricompensata dal suo sorriso e dalla riconoscenza sul volto, sono rimasta in piedi una ventina di minuti, finché non si è liberato proprio il posto di fronte al suo. La schiena mi faceva male, ma il cuore era allegro.
Ricompensata dal suo sorriso e dalla riconoscenza sul volto, sono rimasta in piedi una ventina di minuti, finché non si è liberato proprio il posto di fronte al suo. La schiena mi faceva male, ma il cuore era allegro.
Mi è tornata in mente una frase di un maestro Zen letta chissà dove, ovvero che è proprio quando siamo emotivamente in difficoltà, quando ci manca il coraggio, che dobbiamo alleviare gli altri dalla sofferenza, incoraggiarli.
Come a dire che rivolgersi all’esterno, anziché all’interno, talvolta è la giusta risposta da darsi.
Metà luce e metà buio.
E come premio ulteriore c’è il ricordo. Che, forse per il lavoro che faccio, rimane per me la cosa in assoluto più preziosa. Consapevole come sono di come la maggior parte della vita scorra via senza lasciare alcun segno nella memoria, creare un ricordo è qualcosa di grande valore.
Lo scrivo, insomma, perché lo ricordo.
 È solo allora che noto come la mia ombra, in quel pezzo di asfalto, si fosse mescolata alla sua. Le sorrido. Potrei dire di più ma corredo il sorriso al sumimasen e con dolcezza riprendo il cammino. Sumimasen è una parola che non vuol dire poi molto ma che, per assurdo, è molto robusta nel senso. Ci sono parole così, che si piegano alla voce e al viso, parole in cui è il modo di porgerle che sta il significato.
È solo allora che noto come la mia ombra, in quel pezzo di asfalto, si fosse mescolata alla sua. Le sorrido. Potrei dire di più ma corredo il sorriso al sumimasen e con dolcezza riprendo il cammino. Sumimasen è una parola che non vuol dire poi molto ma che, per assurdo, è molto robusta nel senso. Ci sono parole così, che si piegano alla voce e al viso, parole in cui è il modo di porgerle che sta il significato. Mentre lui corre davanti ricordo che anche questa mattina, davanti alla lavatrice, me la sono riportata alla mente, che l’ho fatto anche ieri scendendo dalla bilancia, che in fondo non ci sia giorno che io non mi ripeta costantemente la frase di Cesare Pavese, la stessa che ho messo in bocca a Clara in Non oso dire la gioia.
Mentre lui corre davanti ricordo che anche questa mattina, davanti alla lavatrice, me la sono riportata alla mente, che l’ho fatto anche ieri scendendo dalla bilancia, che in fondo non ci sia giorno che io non mi ripeta costantemente la frase di Cesare Pavese, la stessa che ho messo in bocca a Clara in Non oso dire la gioia.