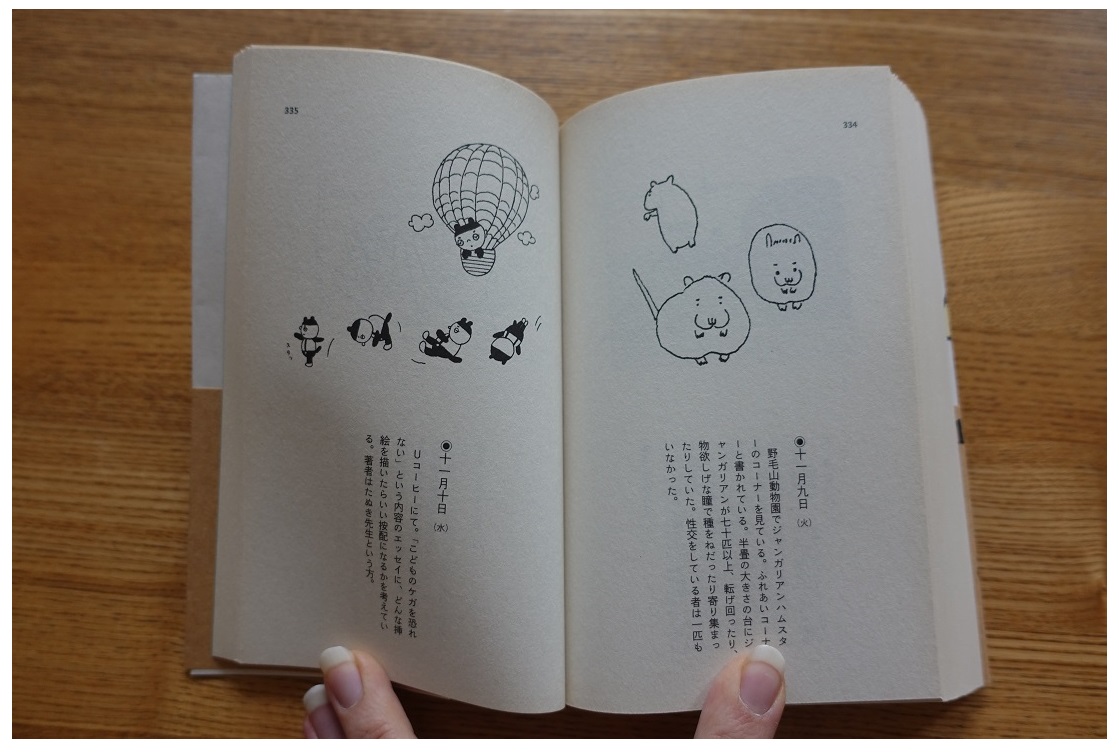Con un cuore legato non si entra nell’impossibile
Mi sveglio la mattina, con l’ansia sottile delle cifre. Della conta cresciuta dei morti, della fila degli infetti.
 Celo il cellulare, con il suo innaturale chiarore, sotto le coperte comuni, il bimbo di fianco che mi sente sveglia e ha una gran voglia di accendere il giorno, di sgambettare per il biscotto, i giocattoli da spartire con il fratello, urlando con quanto fiato hanno in gola.
Celo il cellulare, con il suo innaturale chiarore, sotto le coperte comuni, il bimbo di fianco che mi sente sveglia e ha una gran voglia di accendere il giorno, di sgambettare per il biscotto, i giocattoli da spartire con il fratello, urlando con quanto fiato hanno in gola.
Controllo le informazioni, la posta, i commenti, come percorrendo e ripercorrendo costantemente la medesima strada. Alla fine mi gira la testa, perché anche il corpo lo sente, che è un ruotare un po’ vano, nella millimetrica differenza che fa sapere “ogni cosa”.
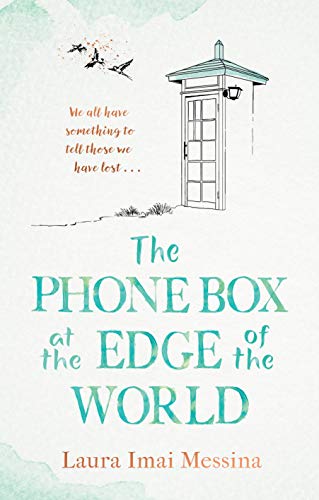 Un altro paese – Israele – che si aggiunge alla lunghissima lista delle lingue in cui uscirà questo romanzo che mi dà tanta gioia. Una gioia certo smorzata dalla contingenza storica che tuttavia so momentanea, perché nella natura nulla è destinato a restare.
Un altro paese – Israele – che si aggiunge alla lunghissima lista delle lingue in cui uscirà questo romanzo che mi dà tanta gioia. Una gioia certo smorzata dalla contingenza storica che tuttavia so momentanea, perché nella natura nulla è destinato a restare.
Dovevo tornare a maggio in Italia. La prossima volta invece, chissà.
Registro brevi video per associazioni, librerie, iniziative diverse, accomunate dalla convinzione – che condivido – che leggere possa aiutare in questo momento. Non per rendersi più “acculturati”, per quando insignificante poi suoni questa parola. Ma per prendere una pausa da se stessi, che in momenti di grande stress serve grande riposo.
Serve uscire (mentalmente) per ritornare rinnovati, mettere in pausa la vita in prima persona che tanto gravosa sa essere per la responsabilità – completa – che essa ci affibbia. I bambini ne ripartiscono il peso con i genitori, ma agli adulti tutto resta, la libertà e l’onere del giudizio. Quanta fatica.
Leggere allora è diventare Napoleone, pensare ai suoi crucci diversi, vederli risolversi, dipanarsi nella sua particolarissima storia; è essere Cristina Campo che lotta per una parola e che, imperiosa e fragile insieme, non smette di cercarla per tutta la vita (Belinda e il mostro) ; è diventare Jack London e vivere tutte le esistenze possibili in una sola, attraversare luoghi così remoti che non ci sono già più (Figlio del lupo); è ricordarsi cosa è famiglia, in profondità (Non è vero che non siamo stati felici). Alcuni li ho appena assaggiati, altri sono già parte di me.
 E poi mi è venuto in mente il lato altruistico della faccenda. Leggere ad altri, perché anche il bene, a se stessi, non è detto che ce lo si conceda. Fare per altri, talvolta, è più facile che fare per sé.
E poi mi è venuto in mente il lato altruistico della faccenda. Leggere ad altri, perché anche il bene, a se stessi, non è detto che ce lo si conceda. Fare per altri, talvolta, è più facile che fare per sé.
In questo leggere ai bimbi aiuta.
Leggete fiabe ai vostri bambini. Di fate e castelli, di minuscoli re e immensi mostri, di magie e maledizioni che aprono con improbabili soluzioni il cuore ai malvagi, di crudeltà indicibili che in effetti non vengono dette, di cuori giganteschi che si strizzano e annaffiano boschi.
Ma leggete anche ai nonni, una fiaba per telefono, magari su Skype, una storia che allaga il cuore di parole diverse, che nulla hanno a che fare con la realtà che ci sta addosso e ci cambia le vite.
Un respiro profondo, ecco cosa è la lettura in questo preciso momento per me. Una pausa dalla propria vita. Un modo di recuperare (energie, libertà, serenità) in un mondo che non è questo.
“Le fiabe insegnano a ragionare alla rovescia, a sconfiggere la legge di necessità e a passare a un nuovo ordine di rapporti. Insegnano a spiccarsi «il cuore dalla carne …poiché con un cuore legato non si entra nell’impossibile».*
L’impossibile, in fondo, coincide spesso con il non immaginato.
E dell’impossibile, adesso, abbiamo talmente bisogno.
*Cristina Campo, Gli imperdonabili, Adelphi




 Yet among the feelings I had in there, there was salvation, actually, it was mostly that. And opportunity. “There’s still time, Laura” I told myself. “Go!”
Yet among the feelings I had in there, there was salvation, actually, it was mostly that. And opportunity. “There’s still time, Laura” I told myself. “Go!”