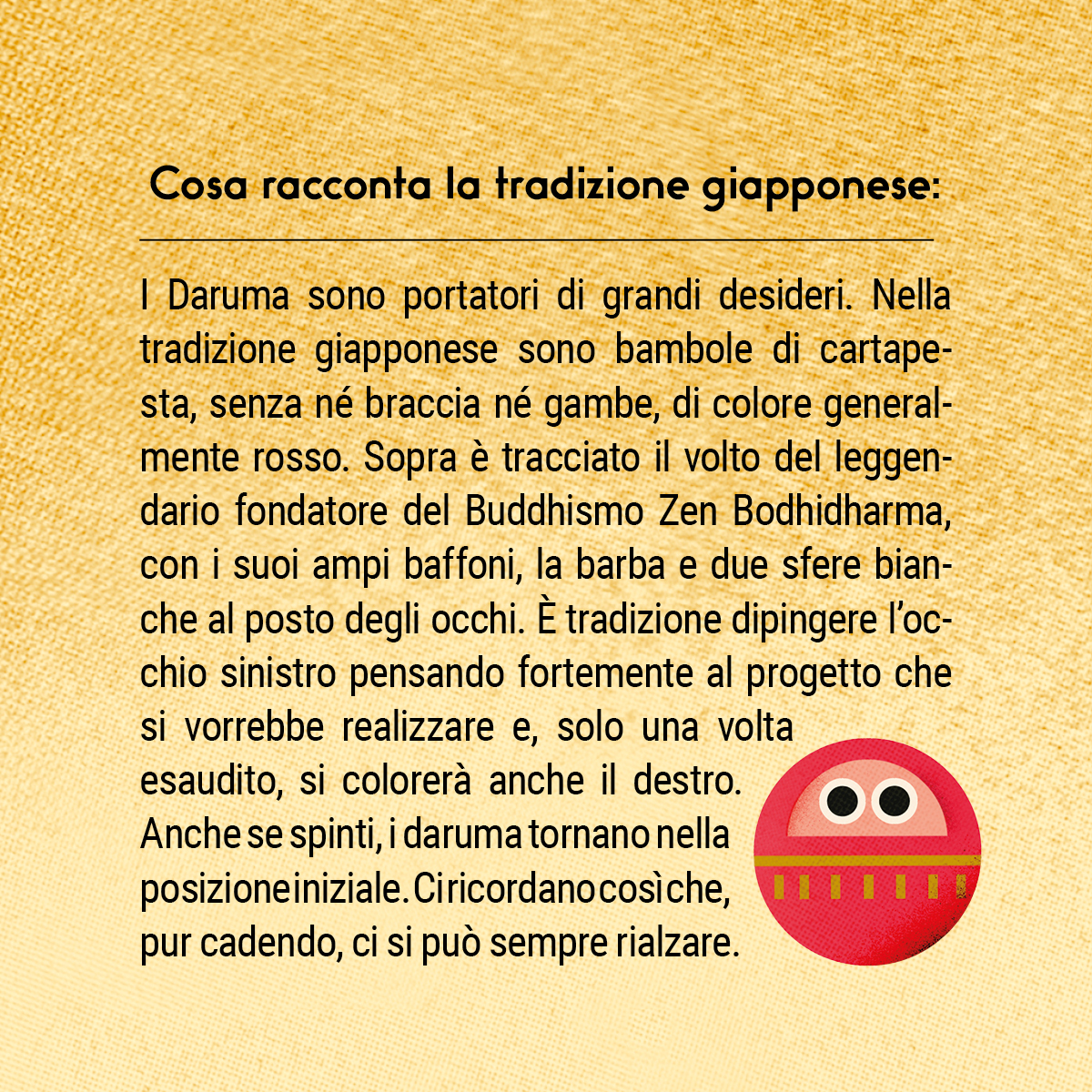Sono finite venti ore.
Ma in venti ore che fai?
Parli, leggi, ascolti. Poi accade un terremoto e ti devi alzare per scomparire dal riquadro dello schermo per salvare un vaso colmo d’acqua (e un solo fiore) che sta per cadere. Ascolti storie, la percezione di im-perfetti sconosciuti di questo strano concetto di «altrove» che, alla fine lo capisci, significa talmente tante cose che forse è proprio una parte del sé.
In venti ore c’è chi riesuma il cuore – che chissà dove lo aveva fatto scappare, chi tira su ricordi belli e atroci e scopre che basta continuare a immergerci le mani per pescarne altri. In venti ore si diventa palombari, e si cerca la bellezza ovunque, si osserva con occhi nuovi la propria via, finestre, portoni, citofoni che erano lì eppure… Ci si accorge che Georges Perec aveva ragione, che le cose per esistere devono urlare.
In venti ore scopri che Murakami in Italia ha scritto «Norvegian wood – Tokyo blues», a Roma «Dance dance dance» e che non è stato felice. Che se ti ricorda Carver c’è un perché.
In venti ore c’è chi trova New York, Hong Kong, Tokyo a Bologna, in Sicilia, chissà dove.
In venti ore si scopre che ci vuole coraggio. Anche a buttare giù i ricordi o un diario.
Il primo giro del mio corso “Raccontare l’altrove” per la Scuola Holden è finito ieri notte.
Scrivere è un modo per ricordare che vivere è collezionare memorie e, per non dimenticare quello che ci accade, serve uno sforzo, l’abitudine a fermare. Serve persino rischiare di non prendere un aereo, di non parlare una parola di giapponese in una ryokan dove la carta di credito non fa il suo mestiere. Imparare cose nuove. Sottrarre le parole.

E per me sarà sempre Carolina che cercava Milano dentro Berlino, Maria che trovava un pezzo di Taranto in Torino, Giulia che ha sollevato tra le dita la sua infanzia, Ludovica che ha troppi talenti e deve scegliere su quale concentrarsi, Alessandra che fa l’ostetrica ma ha un grande voglia di raccontare, Serena che ha la meraviglia persino nelle virgole e nei punti e ama in due lingue e due città differenti, Gabriella e i suoi giardinetti di Osaka che si ingoiano tutte le periferie del mondo, Nadia che trascina nel racconto – qualunque racconto le venga in testa, Paolo che ha una capacità rara di spiegare l’ironia e insieme la bellezza del suo mondo. Chiara che è timida ma ha un grande cuore. Mara che sta defilata ma avrebbe tante cose da dire. Andrea, che ora aspetto il libro e non aver paura di tentare (non averci provato e poi rimpiangerlo tutta la vita: questo sì che deve spaventarti). Davide – che non si capisce perché mai non abbia buttato giù se non un romanzo almeno un blog di successo. Maria Rosa che è timida ma che, quando parla, crea un’aureola di silenzio intorno a sé. Nicoletta che deve mettersi al centro. Patrizia che è pura energia, di quella tempra che sa prendere a morsi la vita. Patrick che quando lo leggi davvero ti pare d’essere risucchiato altrove – e ti invoglia a restare.

Lo dicevo altrove che mi innamoro delle persone. Dell’essere umano nelle persone.
Ed ecco che per me Mara, Alessandra, Serena, Antonella, Nadia, Nicoletta, Giulia, Patrick, Maria Rosa, Ludovica, Andrea, Gabriella, Maria, Davide, Chiara, Patrizia, Paolo, Carolina, anche Carmen che doveva andare e Francesco che aveva esami da fare, sono stati un innamoramento.
E come sempre quando si tratta di “insegnare”, ho la conferma che in nessuna occasione si impara tanto quanto quando si prova a insegnare. Grazie quindi. Grazie di cuore.